Il gravissimo incidente capitato a Kevin Ware, cestista dei Louisville Cardinals, il 31 marzo durante la finale del Midwest Region ha shockato l’intero pianeta sportivo USA e non solo. La guardia che milita nella team dell’Università del Kentucky, dopo aver saltato nel tentativo di bloccare un tiro da 3 punti avversario, è atterrata malamente sul parquet: la gamba destra ha ceduto e la tibia della giovane promessa delle National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha fatto “crack”. La serietà dell’infortunio si è immediatamente percepita osservando la disperazione e la commozione dei compagni di squadra e dei rivali della Duke University. La drammaticità dell’episodio, oltre ad aver toccato la sensibilità degli americani, ha riportato in auge una questione su cui il circolo sportivo accademico d’oltreoceano dibatte da diversi anni, ma che nell’ultimo periodo era stata messa in secondo piano: l’eticità dell’apparato economico il quale orchestra il “giro d’affari” che gravita attorno le promesse dello sport USA.
Tra i tanti pregi che contraddistinguono la configurazione del sistema sportivo a stelle e strisce, prospera un oscuro ecosistema in cui università, dirigenti e aziende private si spartiscono la quasi totalità dei 780 milioni di dollari che produce la “money machine” del basket universitario. Sono esclusi da questa distribuzione dei guadagni i veri protagonisti dello spettacolo, senza i quali lo show non potrebbe esistere, ovvero i giocatori. Gli studenti che fanno parte delle franchigie accademiche non sono considerati professionisti, e hanno diritto a delle borse di studio, le quali spesso non coprono l’intero percorso universitario e, inoltre, possono essere revocate in caso di infortunio.
David Sirota, conduttore radiofonico americano, ha commentato a poche ore dal “caso Ware” il modello economico adottato dal basket universitario: «Gli studenti giocatori che militano nella NCAA hanno diritto a delle borse di studio. Tuttavia, questi contributi di solito non coprono l’intera carriera universitaria. E, soprattutto, sono limitati nel tempo: quasi nessuna università offre contratti per l’intera durata del corso di studi, quindi nel caso in cui un atleta si infortuni giocando per la squadra dell’università, l’ateneo può tagliare la borsa di studio. Ed è quello che di solito fanno tutte le università». Atenei a cui non spetta pagare le cure mediche, le quali inevitabilmente ricadono sulla famiglia. L’Università di Louisville, la quale vanta la squadra più redditizia dell’intero basket accademico degli Stati Uniti, si è schierata contro la proposta di costringere gli atenei a stipulare contratti che durino sino al termine degli studi.
In seguito al “caso Ware” la rete è stata invasa da proteste e polemiche in merito a questo microcosmo economico, ed è stato frequentemente riproposto l’eccellente articolo pubblicato dall’Atlantic nell’ottobre del 2011, intitolato The shame of college sports. “È uno scandalo che studenti-atleti che fanno guadagnare miliardi di dollari alle loro università e alle aziende private non guadagnino niente”.
La buona notizia è che l’operazione alla tibia di Kevin non ha incontrato difficoltà, e il ragazzo ha già promesso: «Tornerò». Rimane l’interrogativo riguardo a cosa troverà il giorno in cui riapparirà sui parquet del torneo NCAA: ancora un sistema ad appannaggio dei “poteri forti” o un apparato più “giusto” che tuteli i giovani sportivi e le loro famiglie? Se “non tutto il male viene per nuocere” l’auspicio è che lo sfortunato Ware divenga il simbolo di una “battaglia” per un’equa distribuzione dei profitti che comprenda lui ed i suoi colleghi.





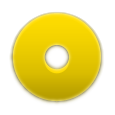



Nessun commento
There are currently no comments on Quando lo sport diventa business: il “caso Ware” scuote il basket universitario USA. Perhaps you would like to add one of your own?